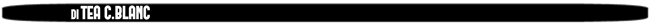 C’è un racconto di carattere nero dello scrittore statunitense Nathaniel Hawthorne, “La figlia di Rappaccini” (Rappaccini’s Daughter, 1844, in seguito comparso nella raccolta Muschi da una vecchia canonica, Mosses from an Old Manse, 1846), anticipatore del genere letterario fantascientifico, una storia senz’altro conosciuta dagli amanti della letteratura fantastica, dove in questo caso per fantastico intendo un’idea fuori dall’ordinario sviluppata su una realtà ordinaria, ma che una volta trapiantata snatura la realtà pur continuando a rispettarne i canoni, acquistando piena credibilità e una sua logica intrinseca per dare luogo alle relative conseguenze.
C’è un racconto di carattere nero dello scrittore statunitense Nathaniel Hawthorne, “La figlia di Rappaccini” (Rappaccini’s Daughter, 1844, in seguito comparso nella raccolta Muschi da una vecchia canonica, Mosses from an Old Manse, 1846), anticipatore del genere letterario fantascientifico, una storia senz’altro conosciuta dagli amanti della letteratura fantastica, dove in questo caso per fantastico intendo un’idea fuori dall’ordinario sviluppata su una realtà ordinaria, ma che una volta trapiantata snatura la realtà pur continuando a rispettarne i canoni, acquistando piena credibilità e una sua logica intrinseca per dare luogo alle relative conseguenze.
Si contano numerose le edizioni in traduzione italiana, sia in versione cartacea che in ebook, sia in raccolte che come singolo titolo. Semplice da leggere anche in lingua originale, nonostante gli innumerevoli arcaismi.

Racconto anticipatore, dicevo, e assolutamente moderno perché indaga il ruolo della scienza, i suoi limiti e la necessità di un’etica che ne controlli l’applicazione. Un dibattito annoso in ambito moderno, e secolare in quello storico, mai risolto, che ha prodotto squarci psicologici e ripensamenti gravi negli scienziati contemporanei o appena contemporanei i quali hanno assistito all’impiego bellico dei loro studi (a cui si è unita in seguito anche la triste variante economico-politica, altro luogo dove di etica non ne esiste, o perlomeno non sta dimostrando di averla).
Dibattito molto attuale oggi dove per molti c’è una percezione contraddittoria nei confronti della scienza quasi avesse le qualità di una fede religiosa, e che registra una parte della collettività umana pronta a credere alla scienza. Ma la fede, che si fonda su costrutti non spiegati e non comprovati scientificamente, dovrebbe essere la negazione stessa dei principi su cui si allinea la scienza. D’altronde anche la scienza è perfettibile, e ciò che non può essere spiegato oggi potrà forse esserlo domani in seguito a nuove scoperte e nuove tecnologie. Oppure c’è anche il caso che molto di quello dato per certo scientificamente in passato si è rilevato erroneo con gli occhi del dopo.
 Nathaniel Hawthorne in una fotografia scattata da Mathew Brady (circa 1855-1865)
Nathaniel Hawthorne in una fotografia scattata da Mathew Brady (circa 1855-1865)
L’autore del racconto, Nathaniel Hawthorne (Salem, 1804 – Plymouth, 1864), è anche il creatore dell’indimenticabile “La lettera scarlatta” (The Scarlet Letter, 1850) che riscatta con la sua penna i fiumi di sangue innocente versato durante il processo alle streghe di Salem nel Seicento. Molta critica lo ha visto alle prese con il pesante senso di colpa proveniente dal fatto che uno dei suoi avi avesse partecipato ai processi come giudice e promotore di quello che non si può definire altro che un triste abbaglio collettivo e un assassinio ingiustificato.
In questa storia di cui parleremo, Hawthorne ci porta a Padova dove un giovane di buona famiglia, Giovanni Guasconti, arriva per proseguire gli studi universitari.
Fin qui niente di strano, se non fosse che già dall’incipit in cui viene raccontato il suo ingresso nella “tetra stanzetta” (ha pochi ducati d’oro in tasca e minime possibilità finanziarie) dell’antico palazzo che lo ospiterà, cade subito un’ombra simbolica.
D’altronde Hawthorne è, insieme a Edgar Allan Poe, scrittore gotico per eccellenza e chi ha qualche dimestichezza con questa letteratura sa bene come atmosfere ordinarie d’un tratto si irrigidiscano facendosi sinistramente presaghe di eventi oscuri attraverso particolari buttati lì “quasi a caso”. Per noi il presagio è l’Inferno di Dante: il nostro giovane e colto protagonista, infatti, indovina subito nell’antico stemma mai tolto dalla facciata del palazzo, che una volta apparteneva a un’antica famiglia ormai estinta e che sarà la sua casa temporanea, il cognome di almeno un personaggio che Dante aveva posto nei gironi infernali dedicati a chi era stato violento contro il prossimo. Cognome che non è esplicitamente citato dall’Autore, ma potrebbe essere benissimo Ezzelino III da Romano, il reggente spietato e tirannico della Padova del tredicesimo secolo che ebbe come quarta e ultima moglie Beatrice, guarda caso proprio il nome della seconda grande protagonista del racconto, la figlia del dottor Rappaccini, una ragazza che il giovane universitario scorge nel giardino a cui si affaccia la finestra della sua stanza. Splendidi entrambi, la ragazza e il giardino, ma per qualche motivo che il giovane non sa spiegarsi anche sinistri.
Gli altri due protagonisti sono il professor Pietro Baglioni, docente di medicina e amico del padre del giovane, che Giovanni andrà subito a visitare per porgergli i saluti del padre, non appena arrivato, e dal quale sarà messo in guardia sul proprietario del giardino – una figura solo in apparenza di sfondo e che dovrebbe rappresentare lo scienziato buono, etico.
E il secondo lo stesso dottor Giacomo Rappaccini, illustre scienziato, tra i migliori a detta dello stesso Baglioni, ma con riserve in parte taciute e in parte esplicitate che gettano il giovane in mille domande a cui non trova risposta.
Un quinto personaggio, la vecchia donna che amministra il palazzo dove abita Giacomo e che vediamo subito alle prese con una ospitalità un po’ equivoca o forse solo appiccicosa, si vedrà poi, completa il quadro.
Il racconto ha avuto anche una trasposizione cinematografica nel 1963, diretta dal regista statunitense Sidney Salkov: L’esperimento del dottor Zagros (Twice-Told Tales), un lavoro che raggruppa tre episodi tratti da opere diverse di Hawthorne: L’esperimento del dott. Heidegger, La figlia di Rappaccini, La casa dei sette abbaini. Qui è possibile vedere un trailer dei tre filmati.

A parte la tematica scientifica, i due motivi strettamente romantici che sono riflessi dalla penna dell’Autore risiedono nella natura maligna e venefica (basti pensare a I fiori del male di Charles Baudelaire o a Giovanni Pascoli) che qualcuno ha ipotizzato come metafora dell’inconscio e dei suoi impulsi fuori da ogni controllo, e in quello della donna angelo e innocente che però, in questa sede, mostra anche una faccia opposta suo malgrado.
Il racconto dà l’impressione superficiale di essere molto semplice.
In realtà Hawthorne mette in gioco parecchio, come abbiamo visto, e perfino nel contrasto tra Bene e Male arriva a conclusioni sconcertanti attraverso la figura dello scienziato buono che, per amore del bene (ma forse ci sono anche sommerse ragioni personali?) lacera in modo molto sottile quel confine che dovrebbe separare nettamente il male dal bene. Hawthorne non si pronuncia, lascia al lettore decidere.
Il tema della scienza trasgressiva e pericolosa non è così nuovo come possa sembrare. Il mondo occidentale se lo porta dietro fin dal Vecchio Testamento dove si parla di sapere pericoloso. Gli alchimisti, precursori della moderna chimica, di questo sapere pericoloso ne fecero le spese additati a stregoni e perseguitati come bestemmiatori contro Dio. È solo con l’Illuminismo e fino al XIX secolo che la figura dello scienziato acquista una valenza di concretezza, di uomo che modifica la natura in modo oggettivo e, allo stesso tempo, in virtù di questa operazione promette un incremento del benessere per l’umanità.
È anche il periodo in cui nasce, per contrapposizione, il timore che la scienza possa sfuggire al controllo umano e sforare in eccessi pericolosi, quando non catastrofici.
Lo testimonia bene la letteratura dell’epoca (in cui rientra anche questo racconto di Hawthorne) che nel suo immaginario dà vita al simbolo dello scienziato pazzo in cui uno dei temi dominanti è la creazione di una vita artificiale.
Della ricchissima casistica accenno solo ad alcune opere, il Faust (1808) dello scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe, Frankenstein (1818) della scrittrice londinese Mary Shelley, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (1886) dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson, L’isola del dottor Moreau (1896) dello scrittore britannico H. G. Wells.
Letteratura che non ha mai perso di vista le implicazioni specularmente negative del tema scientifico e che trovano in tempi più moderni, nel Novecento, una rivisitazione esoterica vista attraverso la mitologia ebraica e il folclore medioevale in Il golem di Gustav Meyrink (1915, ma era uscito a puntate su una rivista tra il 1913 e il 1924), dove appunto si parla del golem, una leggendaria forma di vita artificiale attivata da alcune lettere della Cabbala.
Di assoluto rilievo per il nostro argomento, inoltre, l’analisi agghiacciante nel romanzo Il mondo nuovo (1932) dello scrittore britannico Aldous Huxley, seguito dal mirabolante saggio Ritorno al mondo nuovo (1958).
Temi, timori, problemi e aspetti che ci provengono direttamente dall’epoca degli antichi alchimisti, compreso quello dell’homunculus, così era chiamata l’antica forma di vita artificiale.
 Un fotogramma tratto dal film tedesco muto “Il Golem” (Der Golem, 1915) diretto da Paul Wegener ed Henrik Galeen
Un fotogramma tratto dal film tedesco muto “Il Golem” (Der Golem, 1915) diretto da Paul Wegener ed Henrik Galeen
 Nel manga e nella serie anime “Fullmetal Alchemist” (scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, 2001) gli omuncoli sono tra i protagonisti principali
Nel manga e nella serie anime “Fullmetal Alchemist” (scritto e disegnato da Hiromu Arakawa, 2001) gli omuncoli sono tra i protagonisti principali
La letteratura gotica (e dell’orrore) da qualcuno è ritenuta un genere letterario che affiora in momenti di destabilizzazione sociale e culturale. Momenti che sopravvengono nella collettività in seguito a forti cambiamenti (lo erano stati, infatti, i periodi della crescente industrializzazione ottocentesca con tutti i problemi psicologici e sociali connessi), producendo una crisi culturale e di identificazione di se stessi e degli altri. Il gotico risponde a questa paura producendo un fantastico direttamente collegato all’inconscio e all’irrazionale, mettendo a nudo quali sono questi terrori.
Non è un caso, solo per fare un paio di esempi, se negli ultimi anni il genere distopico ha trionfato anche nelle sue forme deteriori di splatter, dove distopico ha assunto il valore di orrore, come nel caso della fortunata serie televisiva statunitense The walking dead, basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman nella quale si racconta di una società postapocalittica in cui i sopravvissuti tentano di ricominciare una nuova vita (The walkind dead esempio di post-post-gotico?). E non è nemmeno un caso se sono stati portati (giustamente perché sono dei grandi, ma esistono anche altri indiscussi maestri di altra letteratura) alle stelle le opere di Edgar Allan Poe e di Howard Phillips Lovecraft soprattutto nella fascia di lettori più giovane.
La rilettura dei maestri del passato, quando non pilotata ma sorta spontaneamente, nella sua scelta di genere e autori racconta cose importanti sulla società che li rilegge.
Che questa nostra sia epoca di forti e veloci cambiamenti non è una novità. Che ci sia una crisi su vasta scala e in diverse direzioni, nemmeno. Che ci si sforzi di presentare troppo spesso solo il bello in via ufficiale, anche. Ma probabilmente l’anima umana non si lascia abbagliare fino in fondo e ci sta dicendo che nutre orrore per i possibili risvolti di tutta quella tecnologia e quella scienza che, senza una forza che le contrasti per addolcirle e mediarne la potenzialità negativa, presentano i numeri perfetti per risvolti catastrofici.
È però da rilevare che questo orrore non è tanto nei confronti della scienza e della tecnologia (che l’uomo antico invece vedeva come una bestemmia verso Dio), ma piuttosto verso chi ha gli strumenti per poterle dirigere e piegarle ai suoi voleri (dunque dal divino si è scesi allo stesso umano). Nell’apoteosi del già sopracitato The walking dead, infatti, non è tanto lo zombie che fa orrore quanto il genere di essere umano che affiora nel disastro (pensate al peggio e avete pensato giusto).
Scienza e tecnologia sono progredite, a quanto pare ha invece fatto ben pochi passi la saggezza umana. E basta uscire di casa per vederlo.
Per dirla alla Isaac Asimov, nel suo spassosissimo quanto tragico e disincantato racconto, siamo progrediti come una Razza di deficienti!.
Che impiego etico di scienza e tecnologia possiamo aspettarci?
Tea C.Blanc

